
Non so un bel niente di fotografia.
E tuttavia, complice la straordinaria e indomabile intraprendenza femminile, la mattina di sabato 21 marzo mi ritrovo allo Spazioforma, a gironzolare come un’anima in pena tra i potenti chiaroscuri di Mario Giacomelli, il grande maestro della fotografia italiana. Se lo scrivono a lettere cubitali al principio della mostra, che diamine, sarà vero.
Infatti, la mia accompagnatrice (ciao Mari) e tutti gli altri spettatori della mostra procedono lentamente tra i quadretti nerastri, si soffermano a lungo, a volte parlottano tra loro indicando quel punto o quell’altro dell’immagine che hanno davanti: origlio i discorsi di un paio di giovanotti vestiti alla moda e non capisco una sola parola. Linguaggio tecnico.
Nelle movenze di tutti appare evidente un rispetto che rasenta la reverenza e negli sguardi concentrati, tra l’interessato e il sinceramente stupito, colgo qualcosa di simile al segreto.
Probabilmente questo mi accade perché io, dal canto mio, non so bene cosa guardare, dove guardarlo né come guardarlo.
E quanto guardarlo, soprattutto: alcuni spettatori se ne stanno immobili come stoccafissi davanti alla medesima immagine per il tempo a me sufficiente per percorrere la mostra nella sua interezza (e le fotografie esposte sono quasi duecento!): chissà che cosa ci vedono, mi chiedo, o meglio che cosa riescono a vederci: all’inizio l’esperienza artistica di questa mattina mi crea qualche difficoltà perché, come accade con tutti i grandi maestri della storia, al primo assaggio ogni loro performance ci appare in un’aura vagamente elitaria: o ne capisci o tanto vale che non ci provi neanche, brutto ignorante che non sei altro.
Questa sensazione è però un elemento necessario all’incontro con la bellezza; in verità, è la conferma dell’importanza di ciò a cui si sta davanti. Non è bene fidarsi di quei prodotti, artistici o meno, che al primo assaggio donano già una vacua sensazione di benessere: ciò che è grande, all’inizio, deve sempre fare un po’ di paura.
L’arte, la sua esperienza estetica, non richiede cultura o preparazione: richiede umiltà e coraggio.
Armandomi dunque delle suddette qualità mi accingo alla contemplazione delle fotografie: con un sospiro intimorito e incerto mi concentro sulla prima.
Si chiama L’approdo: raffigura una nave nera che conquista la costa sullo sfondo di un bianchissimo e confuso mare schiumoso. A sinistra la spiaggia grigia.
Bè, è bella.
La nota mi informa che non si tratta semplicemente della prima immagine scelta per la rappresentazione, bensì della prima fotografia scattata da Giacomelli in assoluto. Per essere precisi la nota biografica dice: “Mario Giacomelli, nato a Senigallia nel 1925, inizia a lavorare a 13 anni in una tipografia. Nel 1952 compra una macchina fotografica e scatta la sua prima immagine, “L’approdo”.
Sticazzi.
Voglio dire: mettiamo, per assurdo, che venga anche a me il ghiribizzo di cimentarmi nella fotografia: vado in un negozio specializzato e compro la Canon, o quello che è, ultimo modello.
Vado a casa e decido di scattare la mia prima foto.
Intanto io non vivo a Senigallia, ma nel cuore della metropoli milanese, e dalla mia finestra non si vede nessun bianchissimo e confuso mare schiumoso, né tantomeno navi nere che approdano da qualche parte.
Ma non è questo il punto.
Io, probabilmente, per fare pratica mi metterei a fare orrendi ritratti di parenti sorridenti o scatterei una foto dal balcone di casa mia, magari al tramonto per avere più atmosfera (e poi chi ha voglia di alzarsi all’alba), contando di produrre qualcosa di minimamente suggestivo più per fortuna che per impegno.
Questo signore scatta la sua prima foto e il risultato è una specie di quadro che avrebbe fatto impazzire gli impressionisti.
Si vede che certa gente per certe cose ci nasce.
Appurato che non devo essere un esperto per godermi la bellezza delle opere, e sinceramente rincuorato dalla scoperta, inizio a gironzolare per la mostra e ogni tanto fingo di capirne, imitando i comportamenti degli espertoni che mi circondano.
Le risorse cognitive che mi restano da questo compito le utilizzo nel sincero tentativo di instaurare, nella mia ignoranza, un dialogo con l’artista attraverso le sue opere.
Alcune hanno una straordinaria potenza drammatica e narrativa.
In particolare, sono poche le fotografie che costituiscono un’opera unica: la maggior parte è racchiusa all’interno di cicli e percorsi che occupano intere pareti.
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi è composta da diversi ritratti, in pose particolari e forse studiate ad arte, dei pazienti e del personale di un ospizio: il dramma della vecchiaia e della caducità emerge con inesorabile chiarezza dalle profonde rughe dei volti e dei corpi, e le loro pose rimandano a un movimento lento e stanco verso una meta che non può essere nominata, ma che si affaccia inevitabilmente alla mente dello spettatore umano. Il titolo pavesiano ci interpella senza pietà e ci fa sentire vicini alle persone ritratte. Non è altro che l’antico argomento del “memento mori”.
Umiltà e coraggio. Andiamo avanti.
Il discorso di Un uomo, una donna, un amore è un vero e proprio racconto per immagini, senza parole eppure pieno di erotismo e di pensiero: seguendo le immagini serialmente disposte, si arriva dalla contemplazione dell’intimità tra due amanti al loro addio causato dalla chiamata alle armi. Le ultime quattro fotografie, una sopra l’altra, mostrano i momenti del saluto: veri e propri fotogrammi, che imitano la tecnica del cinema… o ne anticipano l’intuizione? Persino una lunga storia d’amore può essere narrata con diversi scatti, lontani nel tempo l’uno dall’altro, ma di un addio, dell’ultimo minuto vissuto insieme all’amata, non può andare perduto un solo istante. L’arte dell’attimo e l’utopia del movimento. Parmenide versus Eraclito.
…sto andando fuori tema.
Mi colpiscono molto le immagini dei campi coltivati: sempre in bianco e nero, vengono ritratte dall’alto le righe perfette della semina e le disposizioni squadrate delle campagne.
Dopo un po’ vanno insieme gli occhi… detto così sembra una stupidaggine: in verità, accade qualcosa di magico per cui quelle figure simmetriche e dure, immortalate nelle innumerevoli sfumature possibili del grigio, iniziano ad assomigliare a qualcosa di unico nel loro genere: campi che non sono più campi, ma capolavori di disegno e geometria. Da questo imparo che la fotografia, pur ritraendo per antonomasia la realtà quale essa è, possiede una misteriosa capacità trasformativa: il fotografo non copia soltanto ma, cogliendo il momento e scegliendo il modo, crea qualcosa dal nulla non meno di qualunque pittore.
Altre ispirate serie di fotografie portano il nome di celebri poesie ( A Silvia, Ritorno); colpisce il gruppetto di immagini che porta il nome di Per poesie: scatti di oggetti quotidiani non sempre riconoscibili, fotografati e messi in attesa di essere associati a qualche verso poetico. Questa scelta fa nascere il sospetto che l’artista non si lasciasse semplicemente ispirare dalla poesia per poi trarne un’immagine, bensì riconoscesse nell’immagine, per lui giustamente primaria, i sentori e la bellezza delle opere dei poeti. Anche in questo caso la poesia è riconosciuta nell’immagine, ma si tratta del riconoscimento di qualcosa che ancora non si è trovato: queste immagini messe nel cassetto, catalogate “per poesie”, raccontano l’intuizione di una meraviglia non ancora espressa ma incredibilmente evidente, senza parole, senza concetti; è lo sconosciuto di Lagervist: o ancora, come quelle di Montale, anche le immagini di Giacomelli portano scritto un sicuro “più in là!”.
Ma l’immagine che più mi colpisce, per la quale bisogna tornare all’inizio della mostra, tra le prime opere, è Il misantropo.
La fotografia raffigura un uomo seduto su una sedia in un giardino brullo: è circondato da alberi morti e si copre il viso con lo scuro cappello. Alle sue spalle, compare una cornice vuota il cui bianco della tela illumina l’intera figura.
Questa fotografia mi piace un sacco.
Da una parte, mi sento chiamato in causa, ed è bello quando un’opera d’arte ci dice qualcosa che ci riguarda: è come se l’artista fosse riuscito, tramite il miracolo del suo talento, a conoscerci ancora prima che nascessimo e a produrre per noi un messaggio che attraversa il tempo.
L’opera mi riguarda perché, causa la mia personalità difficilmente trattabile, l’accusa di misantropia mi è stata rivolta un paio di volte ( a dire il vero, di più) e in certi casi sicuramente a ragione.
In un certo senso il misantropo è un tipo che mi piace.
Ci vuole una dose epocale di faccia tosta per essere uomo e avercela con gli uomini; è un paradosso che ha dell’eroico. Qualcuno direbbe che ha anche del profondamente stupido, ma questa è normalmente la reazione di tutte quelle persone che, avendo un bassissimo livello di autostima, non concepiscono che qualcuno possa volere sinceramente bene a se stesso e da questo tragga la sicurezza e la forza per giudicare gli altri. Che, nella stragrande maggioranza dei casi, se lo meritano.
Ma lo sguardo di Giacomelli è così splendidamente analitico da non lasciare spazio ad alcuna ingenuità, né a quella del misantropo né a quella dei suoi detrattori: la sua opera mostra lucidamente il lato oscuro della misantropia, vale a dire la solitudine e il rifiuto di comunicazione. E’ così che il vero misantropo, per evitare l’autodistruzione, deve scendere almeno occasionalmente dal suo piedistallo e ascoltare la ricchezza che ha sede negli altri: altrimenti, la sua pena sarà la vuotezza dell’animo, la povertà del pensiero… l’inesorabile inutilità della tela bianca di chi non ha nulla da dire, perché non ha nessuno con cui condividere.
Bè, che dire? Andate a vedere le opere di Giacomelli!
Come dite? Non capite niente di fotografia?
Mi dispiace, ma questa non è una scusa.
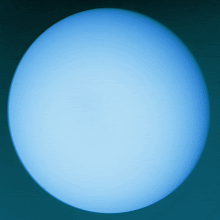
 Clicca qui
Clicca qui 

Nessun commento:
Posta un commento